Lo scorso 5 aprile a Sassari si è svolto l’evento dal titolo “Vaiolo ed ectima contagioso degli ovini e dei caprini: malattie antiche da non dimenticare”, diretto dalla dottoressa Salvatorica Masala, dirigente del Servizio pianificazione della ricerca, formazione e educazione sanitaria dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna, con lo scopo di aggiornare veterinari e operatori del settore di sanità animale sulle patologie causate da poxvirus negli ovini. Il dottor Giovanni Filippini, direttore generale dell’Istituto, in apertura del convegno ha sottolineato l’importanza di portare avanti la diagnostica nel territorio e di trovare un equilibrio tra diagnostica di base e attività di ricerca. Filippini ha ricordato la necessità di ampliare la collaborazione e la condivisione strategica delle informazioni nella rete degli istituti zooprofilattici italiani, anche allo scopo di affrontare con tempestività, sia dal punto di vista clinico che da quello diagnostico, l’eventuale insorgere di nuove patologie. Nell’introdurre i lavori del convegno, il dottor Ciriaco Ligios, responsabile della Sanità animale di Izs Sardegna, ha sottolineato l’importanza dell’approccio clinico e del saper riconoscere i sintomi nel più breve tempo possibile al fine di una corretta diagnosi.
L’esperienza spagnola contro l’ectima contagioso.
Ospite del convegno la professoressa Delia Lacasta, esperta di patologia ovina del Dipartimento di Patologia generale e medica della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’università di Saragozza, che si è concentrata sugli aspetti clinico-patologici, epidemiologici e sulle misure di controllo del vaiolo ovino in Spagna, al fine di fornire, a veterinari e addetti ai lavori, elementi utili al riconoscimento della patologia, nel caso in cui dovessero essere individuati dei casi in Italia. Il responsabile dell’ectima contagioso, un’infezione della cute che colpisce gli ovi-caprini, è ORF, virus del genere Poxvirus.
Dopo aver illustrato la dinamica di diffusione della patologia in diverse regioni d’Europa e nel continente africano, Lacasta ha focalizzato l’intervento sulla diffusione del virus in Spagna, ricordando che attualmente si contano ventotto focolai nella zona di Granada, Almeria e Ciudad Real, per un totale di 48.302 pecore e 478 capre affette dal virus. Lacasta ha sottolineato l’importanza dell’adozione di protocolli di contenimento del virus, oltre alla necessità di riconoscere correttamente e tempestivamente i sintomi clinici, come macule, papule – che contengano una grande quantità di virus – pustole e fistole.

Fondamentale si rivela, in questo scenario, una corretta diagnosi differenziale che consenta di distinguere la patologia da altre che possono presentare sintomi apparentemente simili, come l’afta epizootica, la peste dei piccoli ruminanti, la febbre catarrale e il vaiolo ovino. È stato sottolineato come il virus sia altamente trasmissibile e venga eliminato principalmente tramite l’epidermide, attraverso le lesioni. Lacasta ha ricordato che ORF è molto sensibile alla disinfezione ma che in assenza di quest’ultima, il virus potrebbe resistere sulle superfici fino a sei mesi. Confermando l’importanza della vigilanza passiva, la professoressa Lacasta ha sottolineato il ruolo chiave della collaborazione sanitaria con il continente africano allo scopo di saper riconoscere sintomi specifici e prevenire l’arrivo in Europa di nuove epidemie derivate dalla intensificazione degli scambi economico-sociali, anche alla luce dell’obiettivo di eradicazione della malattia fissato al 2030.
Dalla ricerca di Izs Sardegna importanti informazioni per la lotta al virus ORF.
Nel corso dell’evento, al quale hanno partecipato più di cento persone tra biologi, tecnici di laboratorio e veterinari, il dottor Pintus e la dottoressa Coradduzza, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, hanno riportato i risultati delle ricerche svolte sul tema all’interno dei laboratori di Izs Sardegna. 
Il dottor Davide Pintus ha ricordato che l’ORF, che si localizza a livello dell’epitelio, ha una diffusione mondiale e una forte tendenza a endemizzare, ma una mortalità abbastanza bassa che si attesta intorno all’1%. Nel corso dell’intervento è stato ricordato che la trasmissione del virus avviene per contatto diretto con animali infetti – abrasioni, ferite, escoriazioni e ustioni cutanee permettono l’ingresso del virus nella cute – o per contatto indiretto con oggetti e ambienti contaminati, specie alla luce della elevata resistenza nell’ambiente di questo virus. Per una corretta diagnosi si rivela fondamentale riconoscere i sintomi; da questo punto di vista è stato ricordato che le forme classiche di ectima contagioso sono caratterizzate da croste nel musello, nella regione delle labbra e del naso, dell’occhio, dell’orecchio e, nelle forme più gravi e specie nei soggetti giovani, dalla presenza di lesioni crostose, con la comparsa di papule e macule a livello dello scroto, della coda e del prepuzio; nel corso dell’intervento è stato sottolineato come anche negli animali adulti siano frequenti lesioni a livello mammario. Il dottor Pintus ha concluso riaffermando l’importanza di porre questo virus in una diagnosi differenziale con altre patologie, come bluetongue, afta epizootica, la peste dei piccoli ruminanti e il vaiolo ovino e ha ricordato che l’ectima è un potenziale agente zoonotico che mette a rischio allevatori e macellatori che hanno contatti con gli animali.
La dottoressa Elisabetta Coradduzza, ricercatrice del laboratorio di virologia dell’Izs Sardegna, ha dedicato il suo intervento alle conoscenze filogenetiche sul virus dell’ectima contagioso in ottica One health, ricordando che l’Orf è clinicamente caratterizzato da lesioni di livello medio o severo, sotto forme di vescicole o pustole, con escrescenze proliferative. La dottoressa ha sottolineato che l’ORF colpisce prevalentemente capre e pecore, ma non sono rari i casi anche in altre specie animali e nell’uomo, con conseguente malattia zoonotica: nell’uomo le lesioni del virus Orf sono principalmente situate su parti scoperte, come mani e avambracci e sul tronco, ma anche su viso, cuoio capelluto, occhi e nella regione perianale; la dottoressa ha ricordato come il virus venga favorito da immunodeficienza e altre patologie.
È stato sottolineato come lo spillover non sia però automatico: non tutte le specie possono infatti contagiare l’uomo. Il contagio può avvenire solo attraverso la pecora e tramite specifici ceppi particolarmente virulenti. Questa dinamica consente azioni di management negli allevamenti che consentano di evitare il contagio. 
Coradduzza ha ricordato come al fine di studiare la storia evolutiva di ORF sia stata considerata la variabilità genetica del virus, allo scopo di fornire modelli predittivi e comprendere come il virus si distribuisca in altre aree del mondo. Gli studi realizzati hanno permesso di aumentare del 37% la percentuale dei genomi totali disponibile per il virus ORF a livello mondiale.
La dottoressa ha concluso sottolineando che in Izs Sardegna si sta procedendo al sequenziamento di altri genomi per capire se è possibile confermare l’origine multiregionale del virus: facendo luce sulla storia evolutiva di ORF sarà infatti possibile fornire strumenti predittivi per comprendere come il virus si distribuisca in altre aree del mondo.
Nel continente africano per una esperienza di cooperazione veterinaria.
L’incontro è stato anche l’occasione, grazie alla presenza del dottor Massimo Scacchia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, per un confronto sull’importanza della cooperazione sanitaria con il continente africano allo scopo di conoscere e prevenire l’arrivo in Europa di nuove epidemie derivate anche dalla intensificazione degli scambi economico-sociali. Il dottor Scacchia, da molti anni impegnato in attività veterinarie nel continente africano, ha ricordato come in Africa le malattie degli animali privino le popolazioni di importanti fonti di sostentamento. È stato sottolineato come la sanità animale incida drammaticamente su 750 milioni di persone la cui sopravvivenza è legata alle produzioni zootecniche, oltre ad essere resa ulteriormente difficile dai cambiamenti climatici.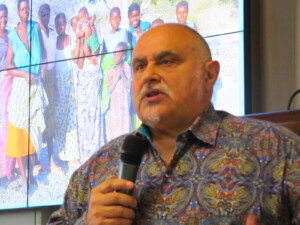
Scacchia, invitando i presenti a partecipare a esperienze di volontariato veterinario in Africa, ha sottolineato il carattere strategico della cooperazione e la necessità si lavorare sul trasferimento delle conoscenze a livello di sanità pubblica veterinaria; Scacchia ha concluso prospettando la possibilità di creare una rete degli Izs che si ponga al servizio del Ministero della Salute e di quello degli Affari Esteri per fornire supporto ai Paesi dell’Africa e acquisire allo stesso tempo conoscenze sul campo su patologie delle quali in Europa non sarebbe possibile fare esperienza diretta.
Fonte: Ufficio stampa dell’istituto zooprofilattico della Sardegna G. Pegreffi













































































